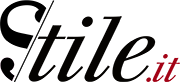Lo aspettavano tutti con ansia da quando pannelli pubblicitari di due piani hanno cominciato a sovrastare le vie delle città con una scritta che sembrava sfondarne la parete: “Australia”. Un film con la ‘F’ maiuscola, di quelli che escono una volta ogni 10 anni e che fanno innamorare un’intera generazione. Grande budget, 120 milioni di dollari, grandi attori, l’eroina Nicole Kidman ed il co-protagonista Hugh Jackman, grande regista, Baz Luhrmann e, naturalmente quando si parla di kolossal, grandi i costumi e le scenografie.
Affidati alle sapienti mani di Catherine Martin, moglie del regista, gli ambienti non possono che guadagnarsi un’attenzione privilegiata. Perché quando si è davanti a una pellicola di sicuro successo di pubblico, ma invisa alla critica dei così detti “polpettoni”, la cura riservata alla riproduzione ambientale costituisce il lascia passare per conquistarsi un paio di seggi nella hall degli Academy Awards. E in fatto di premi, Luhrmann sa di poter contare nella consorte che, già con “Moulin Rouge!”, nel 2001, si era aggiudicata ben due statuette come miglior costumista e miglior direttrice artistica. Oltre alla lista interminabile di riconoscimenti, australiani e non, seguiti a “Romeo + Juliet” (‘96) e “Strictly Ballroom” (’92) che, insieme a “Moulin Rouge!”, completano la fortunata trilogia “del sipario rosso” firmata da Baz.
Australiana D.O.C., come l’intera troupe del film, Catherine nasce a Sydney, città che oggi, grazie a talenti come lei, guida il paese nel difficile compito di liberarsi dall’opinione diffusa che lo vorrebbe solo spiagge, surf e canguri. Frequenta il National Institute of dramatic Arts, dove consegue il diploma e conosce il suo futuro e visionario marito. Con lui iniziano subito le collaborazioni per “Lake lost” (’88) e per i set di “Diary of a Madman” (’89), la “Bohème” (‘90) e “Midsummer Night’s Dream” (’99). Seguono i grandi successi che, interrotti da una delusione professionale – la sconfitta di Baz nella corsa all’epic su Alessandro Magno (poi vinta da Oliver Stone) – le permettono anche di diventare mamma, di Lillian Amanda, nata nel 2003, e di William Alexander che la raggiunge nel 2005.
Impeccabile in carriera, come nel suo ruolo di madre, Catherine ed i suoi piccoli sono inseparabili, tanto da partire insieme, accompagnati da una tata e un documentarista, per l’arido e sconfinato out-back del West Australia. Tre settimane a ritmo di 2000 km ogni due giorni, un viaggio indispensabile per vivere sulla pelle le atmosfere del film, il senso della frontiera, il silenzio di quelle distese sterminate e solo a tratti popolate da forme di vita tribali. E al ritorno, gettarsi a capofitto nella minuziosa ricostruzione anni ‘40 di un pezzo di storia australiana, condita di romanticismo e di tematiche alla “Via col vento” (Victor Fleming ’39), a cui il regista dichiara apertamente di essersi ispirato). L’apoteosi dell’infinitamente piccolo a raccontare il passato ed il presente di un contesto geografico e sentimentale infinitamente grande. Un mosaico d’oggetti “parlanti”, costruito con la precisione del filologo ma senza quell’aurea mussale di tante ricostruzioni, ed anzi, impregnato di vita grazie all’estro e alla sensibilità tutta femminile di Catherine, la ‘certosina’ della settima arte.