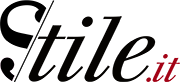Nella vita privata Julianne Moore è madre e moglie felice. Di sera non vede l’ora di tornare nella sua casa di New York, città che ama moltissimo, per riabbracciare suo marito, il regista-autore Bart Freundlich, e i suoi due figli, Caleb, di dieci anni, Liv di 5. Una donna con tutte le carte in regola, con in più la fortuna di essere tra le stelle più acclamate dell’universo hollywoodiano.
Questa è Julianne, almeno per chi ha il privilegio di conoscerla da vicino. Per gli altri, e cioè i milioni di spettatori che la acclamano dalle sale di tutto il mondo, il profilo cambia radicalmente. I suoi ruoli parlano di donne che non potrebbero essere più diverse. Maledette, pazze, drogate e depresse, tendono la corda fino al punto di non ritorno, al gesto estremo, definitivo. È ciò che accade ai suoi personaggi da un certo punto in poi della carriera, iniziata per lei, ragazza di buona famiglia, dopo una gavetta tra teatro e televisione.
Julie Anne Smith, figlia di un militare del North Carolina e di una psichiatra scozzese, come suggerisce la sua chioma vermiglia, nasce a Fayetteville, il 3 dicembre del 1960. Trascorre un’infanzia nomade, seguendo i genitori nei numerosi spostamenti. Poi Boston, dove consegue il diploma, e New York. Qui le prime soap, le mini-serie televisive e, nel ’90, il suo esordio al cinema in thriller di medio spessore in cui già si intuisce l’inclinazione per i film dal sapore malsano. Dal ’95 i primi riconoscimenti del red carpet dimostrano l’avvenuta maturazione professionale. Arrivano le nomination agli Indipendent Spirit Award per “Safe” (Tod Haynes) e, due anni dopo, a Golden globe ed Academy Awards per “Boogie Nights” (Paul Thomas Anderson).
Seguono scritture sempre più importanti da parte di registi del calibro di Joel Coen (“Il grande Lebowski”,’97) e Robert Altman (“La fortuna di Cookie”,’99). Ma è con “Magnolia” (2000) che Julianne inaugura la serie d’interpretazioni che l’avrebbero d’ora in poi identificata con un genere di drammaturgia introspettiva e tormentata. Nel film di P. T. Anderson veste i panni dell’infida moglie, sposata per interesse ad un malato terminale, la quale, a pochi passi dalla fine, si scopre capace di un amore puro che la spinge a tentare il suicidio. Ma questo è soltanto l’inizio. Nel 2002 i ruoli ‘gemelli’ in due film ambientati negli anni ’50, “The Hours” e “Far From Heaven” confermano la sua bravura per una recitazione contenuta ed asfissiante. In entrambi interpreta un alter-ego depresso, una sposa casalinga, trascurata dal marito ed annullata nel suo ruolo di madre.
Acclamata da pubblico e critica, si ripropone oggi sotto le spoglie di Barbara Baekeland, un personaggio di cronaca nera che sconvolse l’America sul principio degli anni ’70. “Savage Grace” racconta la storia dell’ascesa e della caduta di una ricca famiglia americana. La divisione in atti e la struttura epica ospitano una tragedia di portata shakespeariana. C’è l’autodistruzione in seno al potere, c’è l’amore incestuoso di una madre per il figlio, persino duelli spadaccini ma, soprattutto, c’è l’epilogo tragico, assoluto. Il ruolo di Barbara avrebbe fatto gola a qualsiasi attrice in circolazione. Ma Tom Kalin, non ha dubbi e sceglie Julianne. Per i suoi toni sottili, ingoiati, e per la capacità di condurre, per gradi, lo spettatore fin negli anfratti di una psiche malsana.