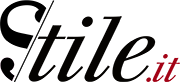C’è qualcosa di più brutalmente sottile di crudeltà e perversione, intrecciati ad immaginari infantili e adolescenziali? Nathalie Djurberg lo sa bene quando cuce insieme i frame dei suoi video dal fascino agghiacciante. Atmosfere idilliache d’ambiente borghese, imperi dell’apparenza che celano, dietro alle tendine di pizzo, tra sorrisi da spot televisivi, carta da parati e fiori colorati, un sottobosco di violenza mentale ed ossessione.
È lo scenario che accoglie il visitatore quando, entrando nel padiglione di “Turn into me”, si trova a vagare nel girone dantesco mascherato da carosello pubblicitario, allestito da Nathalie Djumberg. A Milano fino al 1 giugno, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, ospita le proiezioni dell’artista svedese che oggi vive e lavora a Berlino.
Nata a Lysekil nel 1978, compie i suoi studi alla Hovedskous School of Art di Gothemburg e all’Accademia di Belle Arti di Malmo. I suoi corti d’animazione conquistano la scena artistica europea, grazie alla forza caustica dell’autrice che comincia a collezionare ‘personali’ in importanti gallerie e spazi pubblici europei. È alla Rhodes & Mann Gallery di Londra, alla Giò Marconi di Milano, alla Maze di Torino. E ancora al The Moderna Museet di Stoccolma, al Kunstverein di Hannover e al Nordic Festival of Contemporary Art di Momentum, in Norvegia.
La sua fama oltrepassa l’oceano fino ad approdare nella Grande Mela. È qui che, sulle pagine del “Time Out New York”, Nathalie si vede affidare un importante servizio sulla violenza domestica. Così costruisce quadri alla “Pleasantville” (Gary Ross 1998), interpretati in chiave gotica e popolati da yankee sorridenti, avvolti da un’aura malsana. Questi mostri dai colletti bianchi e pantaloni a scacchi rivivono oggi nei pupazzi di plastilina che animano i filmati di “Turn into me”. Grazie alla tecnica della stop motion (sequenza di brevissime riprese che registrano i movimenti minimi impressi dall’artista ai suoi pupazzi), sottolineata dalla colonna sonora ossessiva di Hans Berg, l’illusione si carica di un pathos da cinema anni ‘20, virato su toni scabrosi e grotteschi.
Macabri paradisi, in cui serpeggiano gli aspetti più cupi e impronunciabili della natura umana. Realtà sussurrate, fiabe moderne che, tra magia e crudeltà, scioccano lo spettatore in bilico tra disgusto e fascinazione. Un binomio perverso che riflette l’intento di un’arte che non si ferma all’evidente condanna delle sacche più nere della società, ma va oltre. Colpisce le nevrosi collettive, stuzzicate dall’ossessione mediatica per la cronaca nera che alimenta, più che sedare, i bisogni di una società ammalata di sensazionalismo.