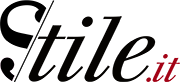Una carriera fulminea la conduce al trono più ambito della Condé Nast, quello di direttrice editoriale di “Vogue America”. La bibbia della moda mondiale le conferisce un potere a cui pochi hanno il coraggio di opporsi. Nata a Londra il 3 novembre del 1949, Anna è figlia di un redattore dell’”Evening Standard”, Charles Wintour.
Cacciata dalle scuole esclusive per il vestiario troppo “audace”, a 16 anni è già giornalista di moda. Lavora per il “British Vogue” e si prepara a saltare i gradini della società americana grazie a una tenacia che, tra le cause del successo, supera il talento di scrittrice. Negli Usa salva riviste sull’orlo del collasso, diventando una leggenda tra gli addetti ai lavori e, nell’88, conquista “Vogue America”.
Il suo nome fa tremare le passerelle. Basta uno sguardo, lanciato dagli occhialoni a prova di flash o una ruga sfuggita all’espressione imperturbabile per stroncare qualsiasi collezione. Oppure un mezzo, quanto raro, sorriso per garantirne il successo internazionale.
Nel 2003 le sue attitudini tiranniche sono raccontate da Lauren Weisberger, ex-assistente martorizzata, nel libro-denuncia “Il diavolo veste Prada” (titolo che allude alla sua considerazione riguardo al made in Italy che comprenderebbe solo l’innovativa Miuccia), seguito a ruota dall’omonimo film (David Frankel ’06) interpretato da Merlyn Streep. Ormai tutti sanno della sua scrivania immacolata, dei cappotti “lanciati” alle segretarie, dei cappuccini ustionanti appena sorseggiati e delle mille idiosincrasie di una personalità viziata dal potere.
E se stilisti e maison soffrono di sudditanza, c’è chi urla al mondo che la “regina è nuda”. È il caso dell’organizzazione anti-fur Peta.org.uk, che se la prende con la sua passione per le pellicce. Durante la London fashion week 2007, la capitale inglese si riempie di manifesti con il volto arcigno della Crudelia della moda e la scritta: “Fur is worn by beautiful animals and ugly people”. A dicembre è tra i protagonisti delle polemiche scatenate dalla trasmissione Rai “Report” che mette in luce gli aspetti più malsani del fashion system mondiale.
Ma l’algida tiranna non batte ciglio e sputa veleno anche sull’ultima settimana della moda milanese, considerata troppo lunga e dispendiosa per gli ospiti “vessati” dal dollaro debole. Le grandi firme si accalcano per compattare i tempi, relegando gli emergenti ai margini del fittissimo calendario. La signora ringrazia ma lancia critiche al vetriolo per la disorganizzazione, responsabile d’attese, doppioni ed accavallamenti.
Stavolta dal backstage qualcuno alza la voce: dal presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Mario Borselli, che respinge le accuse a Mariuccia Mandelli di Krizia che si dichiara indignata, fino a Roberto Cavalli che esplode. Quest’ultimo ricorda i lauti contributi delle maison italiane per la pubblicità sulle pagine di Vogue America e denuncia i newyorkesi di copiarci le collezioni. Gli fa eco Giorgio Armani che, dalla passerella, elargisce la solita lezione di stile.
Ma durante la presentazione al Teatro Manzoni della mostra “Superheroes: fashion and fantasy” (New york, Metropolitan, 7 maggio-1 settembre) il Giorgio nazionale fa opera di diplomazia. Sarà per un senso di “reale” parentela con la regina del jet set newyorkese o perché con lei sarà padrino dell’evento, ma lo stilista ne esalta grinta ed impegno evoluzionista.
Dimentica persino l’insultante Chanel giallo con cui, al party Armani nella Grande Mela, la Wintour consumava la sua vendetta contro il re. Lei, sebbene lo abbia da tempo dichiarato “morto”, ricambia definendolo ironicamente un “superhero of fashion”, accettando la tiepida tregua. Ma la guerra fredda non finisce qui, giocata com’è su un terreno guastato da meccanismi che vanno ben oltre le scelte stilistiche.